La grande Abbazia di San Galgano

L’imponente abbazia cistercense di San Galgano si staglia maestosa man mano che ci avviciniamo, facendoci ammirare da prospettive diverse la sua mistica bellezza.
Ci sentiamo piccoli di fronte alle alte e massicce spalle della costruzione, e questo infatti era l’obiettivo della Chiesa nell’abbracciare lo stile gotico: glorificare ed elevare la potenza di Dio e farci sentire umili, piccole creature al Suo cospetto.
Il culto di San Galgano e la costruzione dell’abbazia

Abbazia di San Galgano viale dei tigli
Un viale alberato da due file di profumati tigli ci porta dal parcheggio delle auto fino ad un punto di ristoro e di sosta, comprendente un bar, un ristorante, agriturismo ed una foresteria. Noi abbiamo fatto una pausa nel bar che offre deliziosi spuntini con prodotti gastronomici locali, scoprendone la bontà assieme alla gentilezza ed alla discreta accoglienza del personale.
La Storia ci dice che il culto di San Galgano si espandeva ogni anno sempre di più e nel vicino Eremo di Montesiepi, primo luogo della zona deputato alla fede cristiana, voluta proprio da Galgano, vennero a stabilirsi i primi monaci Cistercensi.
Col passare degli anni tuttavia chiesero ed ottennero di poter iniziare la costruzione di una nuova Chiesa titolata proprio al culto del Santo. Ciò fu dovuto grazie all’accorrere sempre più numeroso dei fedeli; San Galgano venne elevato al titolo di Patrono di Siena, vedendo accrescere ulteriormente la propria fama anche oltre i confini limitrofi.
Sotto l’impulso di questo primitivo nucleo monastico, ai quali si erano uniti molti nobili senesi e alcuni monaci provenienti direttamente dall’abbazia di Clairvaux (Chiaravalle, casa madre dei Cistercensi), nel 1218 iniziarono i lavori di costruzione della nuova abbazia di San Galgano in questa sottostante piana del Merse.
I lavori vennero finanziati dai nobili su volere dei dignitari ecclesiastici senesi, nonché dalle ingenti ricchezze proprie dei Cistercensi (a quel tempo molto potenti), e non solo.
I monaci ottennero anche che, oltre alla chiesa, vi fosse costruito un adiacente monastero, per trasferirvi un numero crescente di confratelli e di conversi, così da potersi dedicare maggiormente alla divulgazione della parola e del culto di San Galgano. Perciò la nascente chiesa fu subito elevata al rango di abbazia.
Questa comunità religiosa ebbe giurisdizione su un vastissimo territorio tra le attuali province di Siena, Pisa, Livorno e Grosseto, estendendo i propri domini terrieri a dismisura ed acquisendo un patrimonio fondiario a dir poco imponente.
La costruzione della maestosa abbazia di San Galgano, che a detta dei costruttori avrebbe dovuto ospitare più di cinquemila persone, non interruppe tuttavia le funzioni religiose all’Eremo di San Galgano, né diminuì il suo fascino spirituale e misterioso.
La chiesetta infatti venne ampliata su un lato con la costruzione della famosa cappella detta del Lorenzetti, per via degli affreschi del grande pittore senese, nella quale venivano celebrate quotidianamente delle messe in suffragio del Santo.
La Costituzione del Comune di Siena nel 1290 decise di annettere l’abbazia di San Galgano come “casa propria e monastero del Comune di Siena”.
Con questo importantissimo atto la città di Siena introdusse progressivamente il culto del Santo, eleggendolo nel proprio pantheon e ravvisando in Galgano gli stessi valori ideologici che fondavano lo Stato senese. Ed il culto dei fedeli si elevò progressivamente anche e soprattutto intorno alla reliquia della testa del Santo, la quale tuttora si trova nel Duomo della città.
Col passare degli anni, la devozione ed i pellegrinaggi, assunsero numeri assolutamente incredibili per quei tempi, perciò i previdenti monaci pensarono ad una costruzione imponente in grado di accogliere i sempre più numerosi fedeli che, con le loro offerte, contribuivano anch’essi a finanziare i lavori.
A dare l’impulso più significativo ai lavori fu soprattutto l’enorme patrimonio fondiario che i monaci erano risusciti ad accumulare, grazie a donazioni e lasciti e anche grazie a numerose concessioni ecclesiastiche, che permise loro di entrare in possesso anche dei beni delle abbazie benedettine dei dintorni.
Infatti, intorno alla metà del XIII secolo San Galgano divenne la più potente fondazione cistercense in Toscana. Essa fu inoltre protetta e generosamente beneficiata dagli imperatori Enrico VI ed Ottone IV, nonchè dallo stesso Federico II, i quali confermarono sempre i privilegi concessi aggiungendone via via degli altri, ivi compreso il diritto di coniare moneta. Il Papa Innocenzo III inoltre, esentò l’abbazia dalle tasse.
Nel 1262 i lavori erano quasi completati e nel 1288 essa venne finalmente consacrata e titolata a San Galgano.
La grande ricchezza dell’abbazia di San Galgano portò i suoi monaci ad assumere una notevole importanza economica e culturale tanto da spingere la stessa Repubblica di Siena a stringere stretti legami con la comunità cistercense residente nel monastero.
Da allora divenne il centro economico, culturale e politico di tutta la zona, ma dopo una nuova epidemia di Peste seguì il progressivo degrado ed il complesso venne addirittura abbandonato nel XV secolo. Il tetto originario, rivestito di piombo, fu depredato proprio del suo stesso rivestimento nei secoli successivi.
Abbazia di San Galgano, lo stile gotico in Toscana
Dopo questo scorcio storico continuiamo il nostro cammino nel viale che, perpendicolarmente al viale dei tigli, adesso è ombreggiato da file di cipressi, che rendono ancora più mistica l’area attorno a noi ed osserviamo sempre più incuriositi la facciata col suo ingresso principale.



Si notano tre porte d’ingresso, di cui una, centrale, ha un pregevole architrave decorato con foglie di acanto, sormontato da un arco a tutto sesto realizzato con due tipi di pietra diversi, creando il motivo ornamentale bicromatico tanto apprezzato a quei tempi.
Anche le altre due porte laterali, piccole e strette, erano sormontate da archi in pietra, ma dei due archi laterali ne rimane solo uno, a causa del crollo parziale del rivestimento della facciata, conseguenza anch’esso del crollo del campanile sul tetto e su parti della struttura.
Immaginiamo come la facciata col suo rivestimento in pietra integro e completo dovesse essere stata davvero spettacolare e solenne.
Quattro colonne in pietra alleggeriscono l’imponenza della facciata, che misura 21 metri di larghezza (per 72 metri di lunghezza complessiva dell’abbazia). Queste colonne sarebbero servite per la realizzazione di un portico, ma esso non venne mai realizzato. Il fatto che siano presenti tre porte ci fa capire che l’interno è costituito da tre navate.
Tuttavia, ancor prima di visitare questo luogo sacro, sapevamo già che l’abbazia era senza il tetto, dovuto al crollo del campanile avvenuto nel 1786. Pare che la causa fu un fulmine così potente che fece tremare tutta la struttura e che provocò il crollo del campanile addosso alla copertura della chiesa.
Il campanile non venne più ricostruito, così come il tetto e nel giro di tre anni l’abbazia di San Galgano venne purtroppo sconsacrata.
Ciononostante, il complesso abbaziale oggi non ha assolutamente l’aria di un rudere, mantiene invece intatta la sua maestosità aumentandone la suggestione.
Dal punto di vista architettonico, l’abbazia di San Galgano risponde ai criteri della Regola Gotica propria dell’Ordine Cistercense, sia nella scelta della posizione (zona pianeggiante vicina ad un corso d’acqua e ad una importante via di comunicazione, ovvero la romana via Maremmana), sia per la sua forma a croce latina.
E’ stata la prima costruzione gotica in Toscana. Infatti l’edificio ebbe una notevolissima importanza, perché lo stile gotico nell’architettura toscana si diffuse velocemente e fu ripreso come esempio per altre successive costruzioni sacre.
Intorno all’abbazia ed entrando nel monastero
Prima di addentrarci all’interno dell’abbazia di San Galgano, camminiamo lungo il vialetto sul lato destro, circondato da due prati curatissimi dirigendoci verso la reception, ovvero l’ufficio informazioni e biglietteria posto dentro il locale cosiddetto Scriptorium. La visita al complesso è a pagamento e consente di approfondire la storia e la disposizione dei locali adiacenti alla chiesa.
Accostati al fianco destro erano presenti i due chiostri: uno dei conversi, del quale non resta più traccia ed uno dei monaci, del quale resta la ricostruzione di un angolo delle pareti, eseguita intorno agli anni venti del secolo scorso, quando fu deciso di ricostruire alcune arcate con i materiali originari, così da permettere di immaginare la bellezza che doveva avere a quei tempi.



Un passaggio stretto ci conduce verso lo Scriptorium, un locale dove, come si evince dal nome, i monaci copiavano i manoscritti ed i grandi libri miniati.
E’ davvero un ambiente molto ampio, diviso in due navate da cinque pilastri cruciformi che sorreggono delle volte a crociera con decorazioni floreali. Sei grandi finestre su due lati servivano ad illuminare l’ambiente per garantire la luminosità necessaria a copiare i manoscritti.
A quei tempi le copie di ogni libro erano fatte a mano ed adornate con quell’arte nella quale i monaci eccellevano, di cui qualche esempio è arrivato fortunatamente fino ai nostri giorni.
E’ facile immaginarsi questo ambiente mentre ospita i massicci ed alti scrittoi in legno sui quali sedevano i monaci, chini a scrivere col calamo in mano concentrati a ornare di bellissime figure sacre i pesantissimi libri.

Abbazia di San Galgano lo Scriptorium
Il monastero
Visitando questi locali attigui alla grande abbazia viene naturale ed emozionante identificarci con la vita dei monaci di allora.
Anche i nostri passi calpestano lievemente i pavimenti in pietra, per non turbare il pathos che affiora da quelle finestre gotiche, dagli spessi muri, dalle pietre irregolari dei pavimenti, dalle colonne a croce e dagli stretti e scuri passaggi che collegano i vari ambienti.
La sacralità del posto si impossessa di noi. Non siamo soli, altre persone osservano tutto intorno come noi, cercando anch’esse di immedesimarsi nella vita del monastero e provando a fare con la mente un passettino indietro di quasi 900 anni. Ma tutto questo in religioso silenzio, lievemente, per non turbare l’atmosfera di questo museo architettonico così mistico.
Il percorso della visita è obbligato e dallo Scriptorium ci fanno uscire verso il retro del monastero, per oltrepassare la scala di accesso al Dormitorio, dove ci sono le celle dei monaci ed una piccola cappella, al momento non visitabili.
Rientriamo nel monastero non prima di aver ammirato le colline ed i boschi di conifere in lontananza, commentando di come i monaci avessero sempre scelto luoghi incantevoli dove erigere i propri edifici.
Anche stavolta basta guardarsi intorno per confermare l’amenità e la naturale bellezza del posto, cornice di splendido contrasto con la maestosa sacralità dell’abbazia che svetta sopra di noi.
Rientriamo in una Sala chiamata Auditorium.
L’Auditorium, seguendo le regole del monastero, era il luogo preposto all’accusa personale dei peccati di fronte all’assemblea monastica, una specie di confessione in forma pubblica, con le successive discussioni e giudizi da parte della comunità.
Questa sala è collegata da una porta in legno massiccio direttamente alla Sala Capitolare, ovvero uno degli ambienti più importanti del monastero, in quanto vi si riuniva il capitolo dei monaci per deliberare gli atti che riguardavano il governo della comunità. Si tratta di un ambiente molto vasto, diviso in sei campate da colonne abbastanza basse che sorreggono altrettante volte a crociera.





Dopo la chiesa e il chiostro, è la parte più importante di un monastero, e in particolare di un’abbazia. (Si definisce “capitolo” ogni parte della rigida regola scritta dai monaci e quotidianamente letto, un capitolo dopo l’altro, per non dimenticare).
Qui inoltre si svolgeva la maggior parte delle assemblee dei monaci legate al funzionamento del monastero e della sua comunità.
In particolare, si svolgeva anche l’assemblea per l’elezione del nuovo abate. In essa, si svolgevano anche delle celebrazioni liturgiche come l’ufficio della sera, che si celebrava dopo il ritorno dei monaci dal lavoro. Inoltre, sempre qui venivano affrontate le discussioni teologiche, le relazioni sull’andamento del lavoro nella comunità ed anche la richiesta di consiglio ai confratelli da parte dell’abate, in occasione di quelle situazioni particolarmente delicate o preoccupanti da dover affrontare.
Il resto del complesso monastico oggi è scomparso. Nel lato opposto al chiostro, al di là dell’attuale vialetto che conduce alla reception, probabilmente si trovavano il refettorio, le cucine, il focolare, i vari annessi e le latrine.
Stanno eseguendo alcuni scavi proprio in quell’area e infatti affiorano fondamenta di alcuni edifici che sono allo studio degli esperti. Il quarto lato del chiostro era occupato dalla dispensa, dai magazzini e dai locali destinati ai conversi, che la regola imponeva fossero distinti da quelli dei monaci.
Un antico e bellissimo portone a due battenti in legno e ferro separa la sala capitolare dall’esterno, attraversando il quale, un sole luminoso brilla su di noi promettendoci ore molto calde.
Ammiriamo nuovamente i poderosi fianchi dell’abbazia di San Galgano prima di entrarvi, le bifore ogivali sembrano occhi che ci scrutano.

Abbazia di San Galgano – bifora
Entriamo direttamente dalla porta laterale adiacente al chiostro, la quale ha nei fianchi due decorazioni interessanti.
All’interno dell’abbazia di San Galgano
L’imponenza e la spiritualità del luogo spingono il nostro sguardo subito verso l’alto, ad osservare meravigliati lo spazio aperto ed il cielo azzurro racchiuso fra i possenti muri in pietra ed i contrafforti della navata centrale.
Dopo lo stupore, il pensiero corre ad immaginare come questa navata dovesse essere imponente prima del crollo, chiusa con le sue arcate gotiche ogivali ad erigersi ancora più in alto, ancora più su, quasi a voler raggiungere l’Empireo.
Ci si può immaginare la sua incredibile altezza, volgendo lo sguardo alla cuspide del muro di fondo dell’abside. Quello stesso muro che ospita due file di tre finestroni ogivali ciascuno, più un foro dove prima alloggiava un enorme rosone ed un foro più piccolo chiamato oculo, stile che si ripete anche nelle due absidi laterali.
Osserviamo il terreno, oramai in terra battuta, suggestivo in primavera perché vi cresce l’erba a creare un prato verde ed entusiasmante il colpo d’occhio sulle navate laterali, coi loro archi a sesto acuto disposti sia trasversalmente che longitudinalmente, poggianti su magnifici e possenti pilastri a croce e mezze colonne coi capitelli decorati con motivi floreali.
Vedendo il motivo delle navate laterali, immaginandoci lo stesso motivo sulla navata centrale, comprendiamo appieno la bellezza e l’eleganza che doveva avere tutto il complesso.

Abbazia di San Galgano
L’interno dell’abbazia è completamente spoglio e disadorno, nel transetto destro si trova la porta che dà accesso alla sagrestia e un’apertura posta in alto, con la quale i monaci, usando una scala in legno, potevano accedere direttamente dal dormitorio, per non dover uscire all’aperto durante le celebrazioni serali e notturne.
Nella sagrestia sono ancora visibili tracce di affreschi originali, da essa si accede ad un locale usato allora come archivio e chiamato armarium.
Nel transetto di destra come in quello di sinistra ai lati dell’abside furono realizzate quattro singolari cappelle, due per lato, con tanto di lavabo e nicchia per le ampolle ciascuna, supponiamo che siano servite ai monaci per poter assistere gli innumerevoli fedeli al momento della Comunione, suddividendo gli stessi in gruppi.
Ci colpisce l’occhio una rientranza nel muro di sinistra a forma circolare e ci è stato spiegato che era l’alloggiamento per una scala elicoidale che portava al sottotetto.
Accanto a questa rientranza c’è una porta dalla quale siamo usciti dall’interno dell’abbazia, chiamata “porta dei morti” in quanto da lì uscivano i defunti dopo la funzione per essere seppelliti nell’attiguo cimitero. Il cimitero a quei tempi si trovava attorno a quella piccola cappella adiacente all’abbazia, che oggi è usata come magazzino.
Guardiamo ancora una volta i bastioni ed i contrafforti della maestosa costruzione prima di andarcene, portandoci dentro i ricordi di una bellezza imponente che ha sfidato il tempo sopportando gli eventi nefasti, ma che nonostante tutto è riuscita ancora oggi a conservare la sua maestosa e spirituale sacralità.




Prima di chiudere questo racconto, si fa presente che nel raggio di pochi chilometri da questo posto meraviglioso, sempre nel territorio di Chiusdino, ci sono altri luoghi che varrebbe la pena di visitare. Ecco un breve elenco.
Chiusdino, il paese natio di Galgano, con la casa natìa del Santo, di cui vi parleremo prossimamente.
Riserva Naturale dell’Alto fiume Merse, bellissima area boschiva di macchia mediterranea, con secolari querce dal fusto possente e forre di acqua pulita dove potersi rinfrescare, abitata dal gatto selvatico, dalla puzzola e dalla martora, oltre che dal cinghiale, dal capriolo e dalla volpe.
Molino delle Pile, divenuto famoso per la pubblicità ultraventennale di un grosso gruppo alimentare italiano, è stato eretto nel 1200 dai monaci dell’abbazia di Serena.
Abbazia di Serena, piccolo luogo di culto all’interno di un castello, costruita nell’anno 1004 dai monaci benedettini, per chi ama rivisitare i ruderi dell’alto medioevo.
Per informazioni su orari e biglietterie dell’abbazia di San Galgano potete consultare il sito ufficiale del comune di Chiusdino.










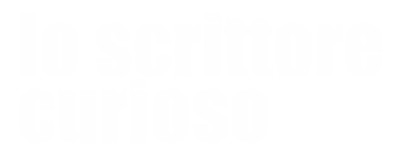
Ricordo di aver visitato l’abbazia per la prima volta in occasione della gita scolastica in quinta elementare. All’epoca non ero a conoscenza del fatto che la struttura fosse priva del tetto. Lo spettacolo di mozzafiato anche per una bambina di 9 anni: varcata il portone, rimasi estasiata dal contrasto del cielo azzurro, del colore dei mattoni e del tappeto d’erba verde. Da allora San Galgano è una tappa obbligata per me e ringrazio per le informazioni trovate si questo sito, perché mi permetteranno un’osservazione più attenta la prossima volta.