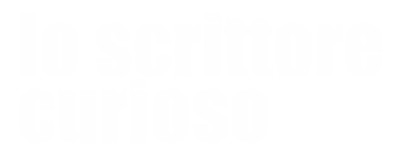Certosa di Calci, una meraviglia barocca in Toscana

Quest’oggi i nostri passi ci hanno condotti a scoprire uno dei luoghi monumentali più importanti della Toscana.
Si tratta della Certosa di Calci, in provincia di Pisa all’entrata di una piccola valle a ridosso dei Monti Pisani chiamata Val Graziosa. Un Monastero di clausura dei monaci Certosini, la cui costruzione iniziò nel 1366 per decisione dell’allora arcivescovo di Pisa e grazie al contributo economico di nobili famiglie pisane, ed è sempre stata sotto la giurisdizione dei Certosini sino al 1972, anno in cui i monaci la abbandonarono definitivamente.
In viaggio verso la Certosa di Calci
La Certosa di Calci dista solo una decina di chilometri dalla magnifica vista della Piazza dei Miracoli di Pisa, proseguendo in direzione Est sulla Via Tosco-Romagnola verso Firenze; in località Navacchio si svolta a sinistra e seguendo le indicazioni si giunge all’abitato di Calci, ma fino a questo momento, della Certosa non si vede traccia.
Lasciata l’auto in una via laterale del paese, seguendo le indicazioni decidiamo di camminare a piedi lungo un viale costeggiato da file interminabili di olivi, una delle ricchezze della zona.
La curiosità diventa impaziente, camminiamo per un bel po’ senza vedere od intravvedere nulla. Il viale svolta verso sinistra e solo a quel punto la vista si espande in autentica meraviglia coinvolgendo tutti gli altri organi sensoriali, intenti nell’ammirare la imponente sagoma della Certosa, con la sua enorme facciata in autentico stile barocco toscano.


Scopriamo la Certosa di Calci
Imponente davvero, maestosa e meravigliosa, dopo il primo emozionante stupore ci chiediamo come non sia stato possibile scorgerla prima. Ma a questa domanda ci diamo subito la risposta, vista la discreta riservatezza che quel luogo deputato alla clausura doveva avere.
Quasi nascosta agli occhi di un mondo superficiale, ma pronta per essere ammirata da chi si spinge con autentico desiderio fino a lei, appare in tutta la bellezza nel suo bianco sfolgorante, che contrasta con l’azzurro terso del cielo di questa giornata.
Essa è la padrona assoluta della scena, olivi, cipressi e i dolci rilievi della Val Graziosa le fanno da cornice, conferendole un’affascinante suprema bellezza.
Una prima facciata fa da baluardo di accesso alla successiva facciata propria del monastero di fattura seicentesca, la cui entrata è costituita da un arco a tutto sesto e da un frontone che lo sovrasta, con un’ode alla beata solitudo.
E proprio sopra la volta dell’arco si legge la scritta latina cartusia pisarum fundata an. rs. MCCCLXVI, che ricorda l’anno di fondazione, contornata da altri due motti dell’ordine negli ovali decorativi ai lati. La statua di San Bruno, fondatore dell’ordine, sovrasta tutto il gruppo dell’entrata.
All’interno sul lato sinistro entrando, c’è la biglietteria collocata nei locali della ex foresteria femminile, infatti la Certosa è Museo nazionale sin dal 1869 e prevede un ingresso a pagamento. La visita è accompagnata da guide, molto cortesi e disponibili a dare ulteriori informazioni oltre a quelle di prassi, per accontentare la curiosità di tutti i turisti.

Certosa di Calci, facciata della Chiesa
Scorcio barocco: ciak, si gira!
Si valica una cancellata in ferro battuto ed a quel punto si apre, anzi si espande la visuale sulla magnifica facciata di fronte a noi, al limitare di un fantastico tappeto d’erba che si estende per tutta la larghezza del fronte di questa scenografia barocca così solenne.
Sembra di entrare in un set cinematografico, il silenzio e la pace regnano in questi luoghi così lontani dal traffico e da altri rumori, anche i passi di noi turisti sembrano ovattati, appena percepibili quasi a non voler disturbare la quiete e l’armonia di questo posto.
Tutto sembra predisposto e costruito per garantire il silenzio, la contemplazione e la preghiera e lo si intuisce immediatamente.
La bianca facciata della Chiesa coi suoi stilemi architettonici e con le numerose statue che la adornano, riempie la scena trascinando i nostri pensieri verso la magnificenza della fede cristiana e delle virtù a cui si dedicarono i monaci Certosini sino al 1972.
Forse sarà grazie al riverbero di luce che illumina queste bianche pareti, e grazie allo sfondo dei verdissimi boschi ed oliveti che delineano questo splendido quadro d’insieme, si ha la sensazione che il tempo si sia fermato per consentirci, nel mistico silenzio, di vivere la pace, il raccoglimento e di percepire, almeno per oggi, la sensibile emozione che pervade il nostro spirito.
Prima di entrare nell’edificio diamo ancora un’ultima occhiata per osservare la simmetria degli elementi di facciata, ammirando i frontoni ai lati dell’accesso della Chiesa, alle cui sommità sono incastonati a destra l’orologio coi numeri romani, a sinistra la rosa dei venti comandata da un pennone che fa ruotare una banderuola in ferro battuto a seconda della direzione del vento.
E poi la doppia rampa anch’essa simmetrica da cui si accede alla Chiesa stessa, il cui portale è sovrastato da un’architrave monumentale sul quale compaiono le statue simboleggianti la Fede e la Speranza, con al centro il monogramma CAR (Carthusia), il tutto sovrastato da una scultura solenne della Vergine in gloria. La facciata inoltre è arricchita di motti e pensieri mistici cartigliati che compaiono un po’ dappertutto.


Entriamo nella Chiesa
Saliamo una doppia rampa simmetrica di scale in pietra per arrivare all’accesso del luogo sacro. La guida ci apre il pesante portone e davanti a noi si svela in un’allegoria di colori e forme, una delle più belle chiese barocche d’Italia.
E’ tutto un susseguirsi di immagini policrome, di stucchi e di marmi: sorprende la parete divisoria in marmo sormontata dalla statua di Gesù piegato dal peso della Croce, che allora separava lo spazio fra i monaci ed i conversi, questi ultimi destinati a restare in piedi nelle celebrazioni religiose, mentre i monaci si potevano accomodare sui meravigliosi scranni lignei intarsiati.
La statua marmorea di pregiata fattura, raffigurante un angelo che funge da leggìo, ci accoglie mentre proseguiamo estasiati all’interno della Chiesa.
Non c’è uno spazio che non sia dipinto, la scelta artistica del trompe-l’oeil troneggia nella Chiesa ed in tutti i locali della Certosa, il soffitto con le sue volte a crociera amplifica la veduta prospettica degli affreschi recanti scene dell’Antico Testamento, le colonne di marmo bianco e di granito rosso e rosa sostengono gli imponenti archi che si susseguono fino ad incorniciare l’altare e la cupola che lo sovrasta.




Questo è una pregevole opera scultorea del XVII secolo, arricchita con statue e marmi policromi che fanno da splendida cornice al dipinto del Franceschini (detto Il Volterrano) che presenta San Bruno, protettore dell’Ordine, mentre offre la Certosa alla protezione della Vergine e del Bambino.
Un gioco di colori e forme così intenso da apparire come un diamante in cui la luce si espande in riverberi e rifrazioni, brillante come un diadema sotto il guscio della cupola semisferica, anch’essa riccamente affrescata ed ornata di simboli mistici.
Il pavimento è anch’esso un’opera d’arte, un vero intarsio in pietra, il cui susseguirsi geometrico di Basalto nero, Arenaria grigia e Marmo bianco, crea un effetto ipnotico così intenso da farci perdere nell’infinito dello spazio tridimensionale che ne consegue.
La Sacrestia e le cappelle votive
Altri esempi di pavimentazioni policrome si alternano, differenti le une dalle altre, nelle stanze seguenti, come entrando nella Sacrestia, una monumentale aula nella quale troneggiano due maestosi armadi altissimi in legno di noce, intarsiati e sormontati da bassorilievi e cornicioni floreali, che rubano la scena alle decorazioni scultoree in gesso e polvere di marmo sovrastanti le ante dorate degli armadi a muro.
Sopra la porta che immette nell’attigua cappella delle reliquie, oltre un dipinto del Bottani, si erge un Coronamento dello Spirito Santo, ovvero l’immagine della simbolica colomba circondata da nuvole ed angioletti, che occupa tutto uno spicchio della volta.
Cappella delle reliquie
La cappella delle reliquie adiacente alla sacrestia testimonia l’immensa ricchezza degli arredi liturgici e dei moltissimi reliquiari di cui era dotata, al punto che dovettero creare questo locale a pianta quadrata per contenere tutti i loro tesori.
Basti pensare che dopo la soppressione napoleonica degli ordini religiosi, i preziosi arredi liturgici in argento e oro furono trasferiti presso la Zecca di Firenze per essere fusi, mentre i reliquiari vennero nascosti presso privati o nella sede vescovile di Pisa, per fare poi ritorno dopo il 1814, ovvero alla fine delle campagne napoleoniche.
Cappella Capitolare
La visita prosegue attraverso alcune cappelle comunicanti le une con le altre, ove i monaci celebravano le loro funzioni private; quindi si attraversa la cappella capitolare, dove essi si riunivano per decidere e deliberare le risoluzioni alle necessità della Certosa, sia materiali che spirituali.





Attraverso altri corridoi si giunge al chiostro principale, chiamato chiostro del Capitolo, del 1471, formato da un porticato continuo sui quattro lati, con una pregevole fontana ottagonale in marmo sormontata da un architrave retto da due colonne e dominato da una croce, posto proprio nel mezzo del prato.
Su un lato dello stesso il piccolo cimitero dei monaci, le cui sepolture sono indicate solamente da croci di ferro e tumuli di terra: non c’è un nome ad indicare chi vi riposa.








Dentro il porticato si ammirano le due finestre a croce che illuminano la cappella del Capitolo, ci sono inoltre porte di accesso che conducono nella maggior parte alle celle dei monaci. In realtà queste non sono “celle” in senso stretto, ma si tratta di locali suddivisi in più stanze, ciascun locale contrassegnato con una lettera e non coi nomi degli “ospiti”, a voler rinforzare il concetto che nel monastero la vita secolare scompare, non ha nessun valore.
Dentro questi locali il monaco vive un ritiro vero e proprio, il cibo viene passato attraverso una finestrella a lato della porta di accesso, orientato in modo tale da oscurare un eventuale contatto visivo fra i monaci stessi. Va ricordato infatti che la cena in comune nel refettorio era consentita solo la domenica o nei giorni di festa canonici; i restanti giorni ognuno consumava i pasti nel rigoroso silenzio della propria “cella”.
Il pavimento in cotto, irregolare, separa le stanze con una soglia in arenaria consunta dai secoli di calpestìo, così come in arenaria sono gli stipiti e l’architrave.
Si entra in una stanza definita “centrale” dove campeggia un caminetto accostato ad un lato del muro e di fronte ad esso una porta a vetri che conduce ad un sottostante piccolo giardino, graziosamente ancora fiorito, provvisto del suo pozzo, a cui si accede da una scala in pietra.
Un umile tavolino ed una sedia sono gli unici mobili presenti nella stanza centrale; nelle nicchie che fungono da armadietti a muro si conservavano le stoviglie e quei pochi elementi del bucato di ricambio.
A destra della stanza, una soglia ci conduce nella minuscola camera da letto, umilissima stanzetta con un letto, un comodino ed un inginocchiatoio sul quale campeggia il Crocifisso. Di lato al caminetto un altro locale, più simile ad un ampio corridoio ospita un lavabo in pietra con la mensola, più avanti un tavolo da lavoro in legno consumato con alcuni attrezzi di falegnameria e più avanti ancora il servizio, ovviamente costituito solo da una seduta in pietra od in legno con il suo orifizio.




Ci siamo dilungati un pochino nel parlare delle celle dei monaci, perché visitando il loro luogo più intimo si percepisce la dura vita e lo spirito di Fede profonda che li ha spinti ad affrontarla, ritenendo pertanto che la “cella” fosse una delle parti più importanti di tutta quanta la Certosa.
Molti sono i registi che hanno percepito la spiritualità della Certosa, da Monicelli a Benigni, da Benvenuti a Campion ed altri, hanno scelto alcune ambientazioni della Certosa per realizzare i loro films, a conferma dell’impressione che ha dato anche a noi come di entrare in un set cinematografico.
Il refettorio nella Certosa di Calci
La visita prosegue e la guida ci porta verso il refettorio, un salone trecentesco affrescato con scene del Nuovo Testamento di pregevole fattura, dove in un angolo si erge un pulpito per le orazioni.








Lunghi e massicci tavoli in legno e panche altrettanto lunghe e solide sono gli unici arredi del salone. Non vi è un caminetto, una porta conduce alle cucine e forse da lì – immaginiamo – doveva provenire l’unica fonte di calore, certamente insufficiente a scaldare tutto quanto il salone. Ampie finestre poste fra gli affreschi donano una debole luce al locale.
Foresteria nella Certosa di Calci
Una grossa porzione della Certosa è dedicata alla Foresteria, tra cui spicca la cosiddetta Foresteria Granducale, destinata ad ospitare i Granduchi, Sovrani di Toscana; nonché la Foresteria Nobile, suddivisa in cinque ambienti, destinata agli ospiti del Granduca od ai personaggi del suo seguito.
Ricche entrambe di affreschi dal classico stile settecentesco, in cui si esaltava il gioco di luci ed ombre per creare l’effetto scenico della tridimensionalità.
Infatti, solo un occhio attento riesce a cogliere la differenza con dei bassorilievi. Altre importanti sculture, stucchi e giochi di marmi policromi completano l’immagine di ricca ed opulenta bellezza delle due foresterie, che si affacciano sul prato tramite pregevoli balconcini in ferro sagomato.







Purtroppo non ci è stato possibile vedere ulteriori locali per via di lavori di restauro, ma restiamo convinti che l’itinerario guidato ci abbia consentito di vedere i locali più interessanti di questo meraviglioso monumento di arte e di spiritualità.
Mentre usciamo, attraversando nuovamente il prato, volgiamo gli occhi verso Ovest, dove la Certosa ha concesso una buona parte dei suoi spazi al Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa.
Un’eccellenza di originalità e di collezioni, dai Minerali al Mondo sommerso (pesci e cetacei), dai Viaggi nella biodiversità sulle orme di Darwin alle realizzazioni di Mostri e soggetti mitologici e fantastici, in grado di espandere conoscenze ed emozioni a tutti, grandi e piccini.

Certosa di Calci, vista dell’entrata del museo di Scienze Naturali
Pertanto ad esso si può attribuire un’importanza di primissimo livello fra le ricchezze museali nazionali, ma di questo ne parleremo in un successivo nuovo articolo.
Per informazioni aggiornate su orari, giorni di apertura e modalità di ingresso consultate il seguente link.