San Galgano e la spada nella roccia

Quest’oggi affrontiamo un tema incredibilmente carico di suggestione e di mistero, ripercorrendo la vita di un Santo che ha lasciato segni indelebili del proprio passaggio ed attorno al quale venne creata una venerazione profonda: San Galgano da Chiusdino.
Vedremo la sua vita speciale che l’ha condotto all’eremitaggio, lasciando simboli misteriosi ed indiscutibilmente significativi lungo il proprio cammino.
Galgano in un epoca di violenze e soprusi
Partiamo dal 1148, presunto anno della nascita del Santo.
San Galgano, ovvero Galgano Guidotti, nacque a Chiusdino, in questo incantevole paese che dall’alto della collina abbraccia la pianura del fiume Merse.
Rampollo di una nobile famiglia locale, esercitò sin da ragazzo l’arte delle armi e divenne ben presto cavaliere in un’epoca in cui proprio i cavalieri ed i nobili nutrivano la loro vita con violenze, soprusi e stupri vissuti come fossero barbari giochi, oscene manifestazioni di vigore, virilità ed arroganza, tendenti ad affermare il proprio potere e ad ampliare la propria sfera di dominio.
La maggior parte dei nobili medievali si trasformavano spesso in crudeli tiranni ed oltre a sfruttare la popolazione erano anche usi a battersi sempre con le armi in pugno, con qualsiasi pretesto vero o presunto tale, ottenendo così terrore e sottomissione.
Galgano non faceva eccezione, anche il suo comportamento in quegli anni denotava arroganza, soprusi e stoltezza. Infatti, nonostante fosse figlio di una famiglia molto religiosa, e fosse stato allevato con molte premure nell’agiatezza, ebbe comunque una gioventù improntata al disordine, alla violenza ed alla lussuria.
Cosa avvenne successivamente in lui fu l’esatto opposto, dovuto ad una visione mistica che gli sconvolse la vita.
La conversione e l’eremitaggio di Galgano
Va ricordato che specialmente i secoli XII e XIII, furono teatri di lotte di potere senza esclusione di colpi, la gente moriva decimata dalla Peste e dalle continue cruenti battaglie che si scatenavano in tutta Europa, macchiando indelebilmente di sangue le pagine della Storia di allora.
Fu forse uno sconvolgimento, forse l’orrore nel non sopportare più morte e devastazione, forse il disgusto delle proprie azioni a seguito di un fortissimo pentimento, fatto sta che Galgano si sentì spronato a convertirsi alla vita religiosa e a ritirarsi in eremitaggio, che visse con la medesima intensità con cui aveva precedentemente praticato ogni genere di dissolutezze.
Ciò che gli diede la spinta effettiva e lo convinse a cambiare radicalmente il corso della sua vita, pare che fu opera di un sogno mistico, legato ad una o più visioni in cui gli apparve l’arcangelo Michele ad indicargli la missione di costruire una chiesa in un luogo solitario, chiamato Montesiepi. Ne parliamo oltre.
Di lui si dice che la sua fu la prima testimonianza di fortissima conversione, poi seguita da altri, soprattutto da San Francesco d’Assisi, che nacque lo stesso anno della morte di San Galgano (1181).
Il luogo che ebbe in visione, ovvero Montesiepi è una bassa collina isolata dalla piana del fiume Merse circostante, a pochi chilometri da Chiusdino, paese natale di San Galgano.
Qui egli trascorse in eremitaggio e in povertà gli ultimi anni della propria vita, morendo alla fine di stenti ma lasciando tracce indelebili di una incrollabile intensità religiosa, spirituale, umanissima e simbolica senza precedenti.

Eremo di Montesiepi
Il mistero della spada nella roccia, i cavalieri e la ricerca del Santo Graal
La leggenda vuole che Galgano, per rispondere alle successive visioni degli Apostoli, smise di usare armi e diventò un mite ed umile eremita.
Forse anche nauseato dai fiumi di sangue che aveva visto spargersi per le terre nella sua vita da cavaliere, fece il voto di rinuncia alla vita dissoluta di allora e soprattutto lasciò la testimonianza di quel gesto simbolico che noi tutti possiamo oggi ancora ammirare, ovvero conficcò la sua spada fra le pieghe di una roccia prominente sulla sommità della collina di Montesiepi, lì dove costruì il suo eremo e dove la spada si trova tuttora.

Eremo di San Galgano – Spada nella Roccia
Questo particolare rivela numerose analogie con le vicende di re Artù e della sua spada Excalibur, con i cavalieri della Tavola Rotonda i quali come sappiamo avevano come scopo primario la ricerca del Santo Graal. Si possono fare diverse considerazioni in questo senso.
Abbiamo accennato precedentemente che nell’oscurantismo medievale si verificarono guerre e battaglie cruenti in tutta Europa, ordite da imperatori, dai re o dai nobili e dai cavalieri negli continui scontri fra di loro, eterni rivali per conquistare sempre maggior prestigio e potere.
Il rifiuto di Galgano all’oscurantismo medievale
I nobili comandavano, la gente del popolo moriva, donando il proprio sangue solo per sottomissione ed obbedienza cieca verso i loro padroni. Ma nello stesso periodo anche altri nobili e cavalieri rappresentanti di fatto della classe dominante, provarono ripugnanza verso una certa condotta di vita, mossi da valori ben più elevati.
Lo dimostra il rifiuto di Galgano, ma anche la coscienza illuminata che ha ispirato la narrazione delle gesta presunte o vere di re Artù e dei suoi cavalieri.
Insomma, oltre la letteratura si sa per certo che molti nobili e cavalieri si distaccarono dalle guerre e dalle atroci regole di allora, molti cercando di operare e diffondere la fede, il bene spirituale e l’assistenza, altri ritirandosi in preghiera ed in solitudine. San Francesco ad esempio ne fu un insigne testimone.
E forse fu proprio la violenza della condotta di vita che portò questi esempi illuminati ad avere visioni per dirigersi verso l’opposto, verso la contemplazione mistica, la carità e l’amore cristiano rivolto al prossimo, magari a costo di sacrifici corporali e rinunce materiali durissime, per espiare la vita precedente.

Basta col sangue versato crudelmente, così decisero alcuni. La ricerca del Santo Graal forse non è altro che un simbolo, forse richiama la volontà di raccogliere quel sangue innocente e versarlo nella Sacra coppa per unirlo al sangue di Gesù, in segno di comunione col Signore.
Anche l’eremo di Montesiepi(chiamato “La Rotonda”) visto dalla base della collina, sembra un calice rovesciato, come se contenesse qualcosa di altrettanto prezioso che unisce quel luogo al Cristo.
La luce di Galgano illumina il buio
In quegli anni il comportamento temporale della Chiesa era molto ambiguo, aveva il potere quasi sempre assoluto persino sulla nobiltà e quindi sul popolo, e lo esercitava in modo non certo esemplare.
Propugnava guerre intestine fra gli stessi nobili, crociate contro gli infedeli, lanciava anatemi e scomuniche a dritta e a manca, dava assoluzioni “cash” dal peccato di omicidio e da altri gravi peccati, giustificandoli come necessari al sostegno della Cristianità. Corruzione ed avidità correvano nei corridoi delle stanze vaticane spargendosi a macchia d’olio su buona parte del clero, insensibile alle condizioni disumane del popolo.
Si sentiva il bisogno di creare un esempio opposto a quel mondo buio e perverso e lo si cercava attraverso una fede purissima ed un comportamento altrettanto cristallino.
Re Artù ed i suoi famosi cavalieri Parsifal, Lancillotto, Galvano (toh: Galwain o Galvano/Galgano…) diedero origine alla leggenda della Matière de Bretagne, ovvero la saga di quei nobili senza peccati che lottavano per la difesa del bene supremo, dell’ideologia benefattrice e della fede cristiana, accumunati nella ricerca del Santo Graal.
Le vocazioni religiose, una nuova spiritualità
Nacquero in quel periodo associazioni e corporazioni dai nobili intenti, soprattutto a ridosso delle crociate, poi estesi in tutta Europa (Templari, Ospedalieri, Teutonici, Cavalieri del Santo Sepolcro, Cavalieri di San Lazzaro….), formati da monaci o nobili e cavalieri in arme, per proteggere, difendere i pellegrini, curare e sfamare i poveri e gli afflitti.
Qui in Toscana erano spesso comuni le vocazioni personali dettate da privazioni, penitenze e contemplazione. E tanta tantissima preghiera e missione di proselitismo delle idee di purezza e di santità.
Proprio alla fine del XII secolo e nel secolo successivo si assistette alla nascita di tanti eremitaggi (romitori) sparsi un po’ dappertutto, dove la vita ascetica di coloro che la praticarono era vissuta dal popolo in maniera molto controversa. Certuni vennero umiliati, alcuni addirittura torturati ed uccisi dall’ignoranza di una parte del popolo che nutriva paura verso la loro diversità, rifiutandola del tutto; altri erano considerati in odore di santità già in vita. Esplicativi sono al riguardo gli esempi di San Galgano e di San Francesco con Santa Chiara, tanto per citare i più famosi.
La visione mistica che cambia la vita a San Galgano
Ma torniamo alla vita di San Galgano.
Secondo le poche notizie storiche di allora, pare che egli iniziò il proprio cammino mistico la notte di Natale, quando l’arcangelo Michele gli apparve in visione chiedendogli di seguirlo.
Lì egli scorse un edificio rotondo, rifinito in modo esemplare ed entrando lo colse un profumo intenso di beatitudine e vide i dodici apostoli che lo attendevano. Gli dissero che in quel punto avrebbe dovuto costruire una chiesa in onore di Maria e di San Michele.
La costruzione della chiesa, desiderio incompiuto di San Galgano
Risvegliatosi, andò subito in paese a cercare dei maestri d’opera per creare la costruzione e così essi iniziarono. Ma servivano denari, li chiese in offerta ai suoi vecchi amici, ma questi rifiutarono e lo osteggiarono credendo che volesse truffarli ed usare il loro denaro per altri scopi.
La costruzione si fermò alle fondamenta, allora Galgano, preso forse da un attimo di sconforto, sguainò la propria spada piantandola su quella roccia sporgente, restando conficcata come fosse una croce. Ed essa, per virtù divina, si saldò alla pietra in modo tale che successivamente né lui, né altri, anche con sforzi immani, riuscirono più ad estrarla.
La leggenda qui si fonde con la realtà, la storia continua dicendo che egli non ebbe i denari per finire la chiesa, ma ne fece una modestissima copertura con dei semplici canneti, sotto i quali giacque fino al resto dei suoi giorni, vivendo di offerte di cibo e di stracci per coprirsi, rinunciando a qualsiasi altro bene.
Ebbe spesso la compagnia di alcuni monaci cistercensi, un ordine già allora molto ricco che in seguito alla sua morte ne promossero la beatificazione, diffondendo la vita e le opere di San Galgano verso la potente Siena e verso tutti i nobili del territorio limitrofo.
Iniziò cosi un’operazione molto strategica di proselitismo da parte di alcuni monaci cistercensi, che accrebbe popolarità e fama di San Galgano, tanto che Montesiepi divenne luogo mistico di pellegrinaggio dei fedeli.
Morte e santità di San Galgano
San Galgano finì il suo cammino terreno il 1° dicembre 1181. Tutti i biografi sono concordi nell’affermare che la morte lo colse mentre era in estasi e che splendeva un’aura di luce intorno alla sua testa.
Le sue biografie si arricchirono da subito di elementi leggendari amplificati, e di contaminazioni, ovvero di quelle emozionanti invenzioni tipiche dell’agiografia medievale e di cui proprio la Toscana e l’Umbria offrirono gli esempi più significativi.
Era un tempo quello, nel quale l’immaginario sacro era assai vivace e sottilissimo il divario fra il reale contenuto e le sue rappresentazioni. Da allora infatti vi fu tutto un fiorire sulle gesta di San Galgano, soprattutto gli storici si concentrarono sui frequenti incontri che ebbe col diavolo mentre era eremita proprio lì a Montesiepi.
Questa collinetta al tempo del Santo era definita da secoli un luogo infestato da demoni e la gente del posto se ne stava alla larga, mentre chi si era spinto nei paraggi avrebbe avvertito le presenze di minacciose ed oscure entità, originando la credenza che fosse un luogo da evitare assolutamente. Furono proprio le battaglie che, sempre secondo gli storici, egli sostenne continuamente con le forze del male ad accrescere a dismisura la fede e la devozione.
I racconti ispirati a queste gesta ebbero come conseguenza una fortissima suggestione sugli abitanti, che col tempo si espanse a macchia d’olio grazie proprio al lavoro di diffusione dei cistercensi.
Nel 1185, ovvero quattro anni dopo la morte di San Galgano, venne terminata la costruzione dell’Eremo di Montesiepi, denominato “La Rotonda” mentre l’ingresso ed il convento attiguo pare che siano del 1200, la cappella degli affreschi invece venne terminata intorno al 1340 ed il campanile un secolo dopo.
Tuttavia le dimensioni originali della chiesa non erano capaci di contenere il continuo e crescente pellegrinaggio di fedeli, per cui si decise di costruire una successiva chiesa, i cui lavori iniziarono nel 1218, ed alla quale venne subito accorpato un convento cistercense facendola così nominare abbazia. La descrizione di questo secondo luogo mistico è riportata nell’articolo La Grande Abbazia di San Galgano.
Per informazioni orari apertura e biglietterie potete visitare il sito ufficiale del Comune di Chiusdino.




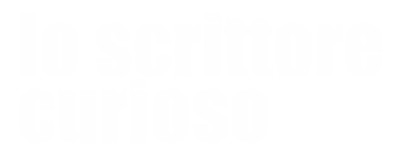
San Galgano, una bellissima leggenda in un luogo eccezionale 🇷🇴